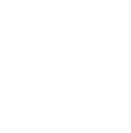di Giovanni Barbetta
 Tomi Bartole, The experience and imperative of not understanding in anthropology: a fieldwork in Papua New Guinea (l’esperienza e l’imperativo di non comprendere in antropologia: lavoro sul campo in Papua Nuova Guinea)
Tomi Bartole, The experience and imperative of not understanding in anthropology: a fieldwork in Papua New Guinea (l’esperienza e l’imperativo di non comprendere in antropologia: lavoro sul campo in Papua Nuova Guinea)
Ciò che segue è la relazione sul resoconto dell’esperienza di dodici mesi (periodo 2013-2014) dello specializzando in Antropologia alla University of St. Andrews di Scozia Tomi Bartole nel villaggio di Awim, nella East Sepik Province (provincia del Sepik orientale) in Papua Nuova Guinea. Il seminario si è tenuto in lingua inglese. Per dichiarata volontà del relatore il seminario non ha seguito un percorso logico unitario; ha invece fornito una serie di stimoli e di spunti di riflessione riguardo la sua esperienza di contatto con un’alterità radicale. Per la diversità degli argomenti e la quantità degli spunti stessi mi sarà possibile riportarne solo alcuni che mi sono arbitrariamente sembrati i più interessanti.
Il primo spunto deriva dal primo contatto in assoluto con la popolazione locale: appena arrivato al villaggio, l’antropologo è stato portato in una capanna e gli è stato dato del cibo e dell’acqua, dimostrando un’apparente immediata accoglienza. Nel momento in cui lui ha finito di mangiare, tuttavia, è stato condotto davanti all’assemblea degli anziani del villaggio che lo hanno sottoposto ad un lungo interrogatorio, domandandogli insistentemente cosa ci facesse nel loro villaggio. Solamente dopo lunghe spiegazioni gli è stato concesso di restare. Dopo un breve periodo di osservazione, il ricercatore ha infine compreso che ogni estraneo è percepito dagli autoctoni automaticamente come nemico, e l’unico modo per convivere nel villaggio è appartenere ad una delle famiglie. Fortunatamente dopo breve tempo un uomo si è offerto di adottarlo, assegnandogli inoltre un nome tradizionale della sua famiglia, Mambian. L’organizzazione familiare è molto complessa e gerarchizzata in clan che si suddividono in sotto-clan o clan minori che a loro volta si suddividono in famiglie, ma paradossalmente non c’è nel linguaggio indigeno tradizionale una parola che traduca “clan” o che ne ricalchi approssimativamente il significato. Come molte altre abitudini e convenzioni, comunque, le relazioni di parentela sono liquide e legate alla ai dati di fatto. Se un giovane vive a casa di sua zia può a buon diritto chiamare lei madre e fratelli i suoi figli.
Un altro elemento linguistico interessante è il fatto che nonostante i villaggi si trovassero in uno stato di guerra permanente tra di loro prima dell’arrivo degli occidentali e degli asiatici, nel linguaggio indigeno della zona di Awim (i linguaggi indigeni in Papua Nuova Guinea sono 800 per circa 7 milioni di persone) non esiste una parola per “guerra” e nemmeno per “pace”, l’unica parola che attenga a quel capo semantico è la parola “poko”, approssimativamente “combattimento”, “conflitto” ma anche “coltellata”, “pugno”, “colpo”, indica quindi sia l’azione complessiva di due o più persone che si colpiscono con intento bellicoso sia la singola azione del colpo in particolare. Un altro aspetto peculiare di questo termine è che, nella cultura dei nativi, sembra avere poco a che fare con la morte. La morte sopraggiunge, ovviamente, ma la finalità del “poko” non è la morte dell’avversario, esso è, in un certo senso, fine a se stesso.
Un ultimo aspetto singolare della cultura del villaggio, forse comune a tutta la zona, è la concezione comunitaria che i nativi hanno dei problemi personali di ogni appartenente alla propria famiglia. Se un membro del proprio clan ha un problema o è accusato di qualcosa, è l’intero clan a occuparsi della soluzione della situazione. Questo deriva dalla credenza che sentimenti come preoccupazione, rabbia, invidia o tristezza attirino gli spiriti maligni che possono far ammalare, o comunque danneggiare, il diretto interessato, ma anche un familiare o un amico stretto. Da qui nasce un sistema diplomatico tradizionale molto complesso che prevede una lunghissima assemblea (può durare da una sola giornata a qualche settimana a seconda dei casi) di entrambe le parti coinvolte e delle loro famiglie (o addirittura l’intero villaggio) al cui termine, dopo un’elaborata cerimonia di pacificazione, entrambe le fazioni si scusano reciprocamente.
Giovanni Barbetta, 5A Liceo Marinelli, Udine