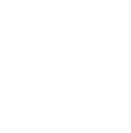FILOSOFIA IN CITTA‘ 2016. Colloqui sull’individuo
Quinto incontro del ciclo Filosofia in città.
Domenica 22 maggio 2016 ore 11, Conservatorio statale di musica “J. Tomadini” di Udine

 Individui e persone
Individui e persone
LUCA GRION e CLAUDIO FRESCHI dialogano su La Persona e il bene comune di Jacques Maritain. Letture di Raffaella Fabris. Musiche di Olivier Messiaen – Riccardo Burato, pianoforte
In questo limpido saggio, Jacques Maritain tratteggia una nozione antropologica destinata a
diventare il simbolo della battaglia culturale del personalismo cristiano contro l’individualismo moderno.  Mentre il concetto di individuo, mutuato dal naturalismo, adombra qui una visione materialistica, la parola persona indica un centro interiore libero e degno di rispetto, una sorgente spirituale di senso aperta alla relazione, al dono, alla trascendenza. In questa luce la persona non rinvia più all’ambiguità della maschera, né all’ordine dell’esteriorità e dello spettacolo, come l’antico termine pròsopon da cui pure deriva. Per converso l’individuo viene privato dei significati morali e civili che il pensiero illuministico gli aveva conferito. Ci si può chiedere dunque se, al di fuori di un contesto cristiano, sia il caso di distinguere in modo così netto le nozioni di individuo e di persona. Se guardiamo all’uso retorico che si … ... continua a leggere
Mentre il concetto di individuo, mutuato dal naturalismo, adombra qui una visione materialistica, la parola persona indica un centro interiore libero e degno di rispetto, una sorgente spirituale di senso aperta alla relazione, al dono, alla trascendenza. In questa luce la persona non rinvia più all’ambiguità della maschera, né all’ordine dell’esteriorità e dello spettacolo, come l’antico termine pròsopon da cui pure deriva. Per converso l’individuo viene privato dei significati morali e civili che il pensiero illuministico gli aveva conferito. Ci si può chiedere dunque se, al di fuori di un contesto cristiano, sia il caso di distinguere in modo così netto le nozioni di individuo e di persona. Se guardiamo all’uso retorico che si … ... continua a leggere